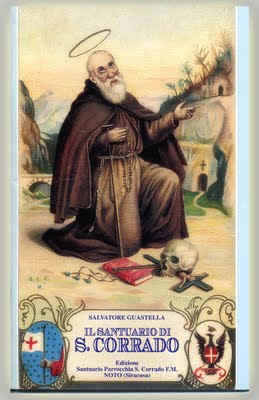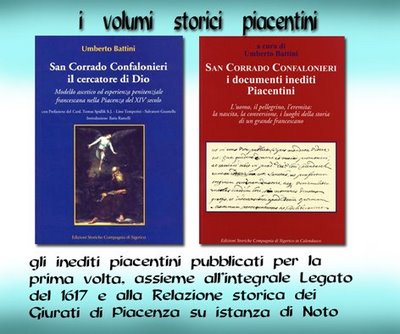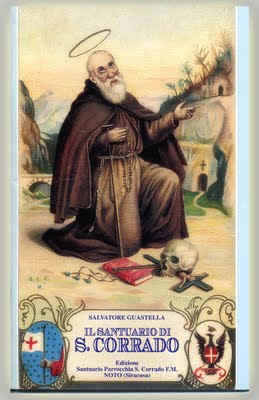

I
DOCUMENTI
INEDITI
PIACENTINI
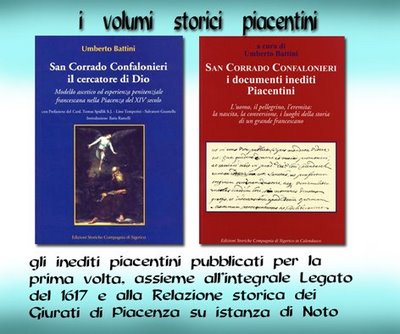
Premessa al volume
In questi ultimi anni a Piacenza c’è stata una riscoperta
molto accalorata della figura del santo piacentino Corrado
Confalonieri. Intorno a questo illustre personaggio si è
sviluppato un nuovo filone di ricerca storica basata
principalmente sui documenti contenuti negli Archivi.
E così è stato necessario rivedere e correggere alcune
vecchie tesi che non avevano base documentale ma che
egualmente la buona fede della gente aveva preso per certe, e
quindi con prove scritte quali sono appunto un atto antico
conservato in archivio oppure una vecchia mappa del tardo 1500
si sono smontate e ricostruite su base scientifica quelle tesi
d’annata ormai superate.
In questo efficace lavoro sono messe in chiaro per
mezzo appunto di documenti antichi e non solo, alcune
questioni che ‘girano’ attorno alla figura del santo di
Piacenza e che interessano lo studioso e l’appassionato di
storia, proprio perchè sono rivolte all’ambiente ed al
territorio che lo hanno visto nascere e convertirsi prima
della partenza per la lontana Sicilia.
E cercando nomi di luoghi sulle carte che datano dal primo
medioevo fino al 1600 e cercando anche sulle nuove ed antiche
mappe si riescono a fare dei collegamenti che uniscono un
territorio ad un modo di essere comune a tutta una popolazione
varia ma unica e disposta lungo l’asse del fiume Po.
Le piccole località scomparse o esistenti, le frazioni
comunali, i corsi d’acqua più o meno capienti, i molini, le
chiese ed i castelli, le strade ed i confini rurali, ancora
oggi parlano a chi è attento di ciò che rappresentano o
hanno rappresentato nel tempo.
Dopo l’eccellente volume “San Corrado Confalonieri il
cercatore di Dio”, edito sempre dalle Edizioni Storiche
della Compagnia di Sigerico di Calendasco nel 2005, che
colmava un vuoto piacentino sull’argomento di bren quattro
secoli, con quest’ulteriore lavoro, la cui cura è stata a
me affidata, si porta alla conoscenza degli studiosi e dei
devoti di Piacenza, di Noto, di Calendasco e di ogni luogo e
dove, di ciò che in oltre dieci anni di silenziosi ma
continui e decisi Studi e Ricerche su San Corrado e la Sua
Nobile Famiglia Confalonieri, sono stati gli esiti a volte
unici, inediti, inaspettati e eccezionali cui ci si è
imbattuti.
Segno questo che la ricerca mai si può dire conclusa, e nel
nostro caso, ha voluto significare che nel piacentino rare
erano state, fino ad ora, serie ed approfondite ricerche
d’Archivio su questo Santo.
Quando circa dieci anni fa mi imbattei nel ‘Legato
Sancti Conradi’, frugando nell’Archivio della
Parrocchiale di Calendasco grazie al significativo appoggio
dell’allora Arciprete parroco don Carlo Maria Ossola, mai
avrei immaginato di fare una scoperta così rivoluzionaria ed
eccezionale sul Santo eremita piacentino cioè che in
Calendasco egli vi fosse nato fisicamente. Queste lunghe e
fitte 27 pagine scritte in latino con la penna d’oca in una
ottima scrittura corsiva, dopo pagine e pagine di dati e
termini giuridici proprii di una Scrittura Pubblica fatta dal
notaio e Cancelliere della Curia di Piacenza Giovan Francesco
de Parma dinnanzi al Vescovo Claudio Rangoni, alla pagina 12
mi indicava senza mezze misure, in modo chiaro e
inconfutabile: che san Corrado aveva avuto la sua origine
terrena qui a Calendasco.
Entusiasta, ma senza eccessiva enfasi comunicai la scoperta a
padre Andreozzi ed altri amici e devoti con me impegnati nel
recupero di questa eccellente Devozione piacentina. Seguirono
i 4 Convegni Nazionali di Studi corradiani, con Partner
Organizzativo la Banca di Piacenza, e nel 3° Convegno di
Piacenza nel 2000, presentai in una relazione principalmente
basata sulle mie scoperte d’Archivio sull’hospitale di
Calendasco, luogo del primo ritiro del Santo alla conversione,
anche ciò che avevo scoperto essere contenuto nel ‘Legato’.
Sebbene la notizia fosse importantissima al momento venne
recepita con le famose ‘pinze’: ma una analisi
scientifica, paleografica e diplomatica dell’importantissimo
documento non ha lasciato dubbi: l’intero Atto è
formalmente perfetto e giuridicamente valido, consegnato e
approvato dal Vescovo di Piacenza perchè in tutto ciò che vi
si affermava, fosse oltre che confermato, pure così
decretato.
In questo Volume al Capitolo 1 abbiamo due importanti
saggi a cura di p. Lino
Temperini TOR, docente alla Pontificia
Università Francescana ‘Antonianum’ di Roma e Direttore
delle Editrici Franciscanum di Roma oltre che della Rivista
Internazionale di studi francescani ANALECTA TOR, in questi
ottimi saggi di Lino Temperini riusciamo a percepire in quale
ambiente sociale e religioso fosse inserito san Corrado, quale
importanza aveva il movimento Terziario dei laici francescani,
uomini e donne, ed ancora di quanto seguito ebbero i Penitenti
Terziari francescani a Piacenza, al punto che scopriamo che
proprio qui a Piacenza nel 1280 vi era stata una riunione
grandiosa che vide confluire Terziari dalle Marche,
dall’Umbria e da tutto il nord Italia, riunione che può
essere assurta quale primo grande Capitolo Generale dei
terziari francescani.
Nel Capitolo 2 sono contenuti una serie di saggi
relativi agli studi che ho personalmente compiuto nel
piacentino, e che vedono essere occorse notevoli
novità che andranno a concretizzare e per certi casi,
rinnovare gli studi datati, perfezionando certe vecchie tesi,
che le nuove indagini d’Archivio hanno portato alla luce,
quali ad esempio ‘il sutta’ e ‘il supra’, e poi la
nascita ed il ‘Legato’ e la concretezza del luogo del ‘gorgolare’,
e dell’hospitale dei penitenti, il luogo dell’incendio, la
questione se il santo fosse o meno sposato ed altri argomenti.
Il Capitolo 3 contiene la lettura paleografica del
‘Legato’ con la trascrizione latina, per mano e grazie
all’esperienza di mons.
Salvatore Guastella, insigne studioso netino, che in
questi anni ha dato alle stampe ottimi e numerosi Studi,
Ricerche e Saggi storici, tra i maggiori cultori ed esperti
della devozione a san Corrado Confalonieri.
Nello stesso Capitolo 3 è contenuta la traduzione dal latino
all’italiano del ‘Legato’ per l’opera paziente ed
erudita del proff. Gianni
Boiardi, colto ed esperto classicista.
Questo Volume nasce quindi dalla cooperazione gratuita e
sincera di tutti questi singoli Autori. E gli Autori hanno
reso concreto in modo storico e preciso il santo eremita
piacentino, contestualizzato in maniera notevole nella ricca
indagine che è stata condotta.
A me, quale piacentino e natio dello stesso luogo del santo
Corrado, spetta l’obbligo e l’onore di ringraziare con
debito profondo di stima e riconoscenza i carissimi p. Lino
Temperini TOR S. Francesco, mons. Salvatore Guastella e il
proff. Gianni Boiardi.
Poter presentare a tutti gli innamorati della storia
piacentina queste pagine, ricche di Studi di eminenti
studiosi, su alcuni aspetti della vita di san Corrado
piacentino, è motivo di grande soddisfazione ed augurio che
possano infondere nel lettore la voglia di guardare con occhio
meravigliato quello che tutti i giorni gli si mostra davanti e
che si credeva non possedesse storia; una storia, quella
civile e religiosa che sono immancabilmente unite insieme e
sempre attuali.
Concludo con una curiosità:san Corrado inizia la sua
‘storia’ andando a caccia, cercando nel fitto bosco la
selvaggina da stanare; quando si converte e poi da Calendasco
parte e arriva in Sicilia, dapprima viene egli stesso reso ‘preda’,
avventandogli contro dei cani; finalmente a Noto, nella sua
bella Valle, in una grotta può darsi alla vita eremitica. Qui
morirà nel 1351. Segue tutto un iter che lo porterà a
divenire prima venerabile per la sola Noto e Siracusa, poi per
tutta la Sicilia ed infine, Santo della Chiesa tutta, e ormai
agli inizi del 1600 è così che a Piacenza si conosce del
Santo piacentino. Calendasco lo ha quale Patrono da subito, da
quattrocento anni, però di san Corrado si era certi solo
della sua nascita ‘spirituale’ nel paese. Siccome era
piacentino, ed i Confalonieri Nobili di questa città, ancorché
in Castrun Calendaschi vi sia la certezza di duecento anni
come loro feudo, non si sapeva con certezza di dove fosse: per
convenzione si diceva nato a Piacenza.
Così a me toccò di ritrovare nel ‘fitto’ di quel
manoscritto conservato nell’Archivio della chiesa di
Calendasco, quella importantissima indicazione storica, che il
Vescovo di Piacenza e i convenuti in Curia ebbero a cuore di
tramandare ai posteri.
Che cioè a Calendasco san Corrado era nato fisicamente.
Quando Corrado andava a caccia, secondo l’uso medievale,
mentre egli attendeva con l’arco già pronto con la freccia
la preda, là nel fitto della boscaglia, tra le sterpi, vi
erano coloro che erano addetti a far rumore, muovere le
sterpi, battere ferri per spaventare la selvagggina e farla
fuggire tra i prati, in luogo visibile, pronta alla cattura da
parte dei cani e dell’uomo. A me è toccato ‘scovare’ il
luogo d’origine di san Corrrado, Calendasco.
Questi servitori e battitori per la caccia, erano detti ‘battini’.
Non sò quanto possa valere, di certo però, io che mai ho
praticato la caccia, ho l’onere di portare questo antico
cognome.
Umberto Battini

L’ASCETICA
DI CORRADO
Breve
sintesi a cura di Michele Di Gabriele
per
“L’Araldo di San Corrado web”
Elaborazione
di un testo inserito nel volume agiografico
“S.
Corrado Confalonieri il cercatore di Dio” – Piacenza 2005
Il
Santo Corrado, si ritirò in un luogo appartato, “secessit
ad remotiora”;
il
luogo appartato è per l’eremita “orationis locus”,
luogo di preghiera.
La
preghiera dell’eremita che si ritira dal mondo è favorita
dal luogo
“adiuta
loco”, è impreziosita dalla solitudine “honorata
secreto”, e arriva
più
facilmente al cielo “facilius nubes...penetraret”.
San
Corrado nella sua vita solitaria ha acquisito particolari
grazie e virtù.
La
vita solitaria è per l’eremita: patria della fede –
fidei sedem – Arca
della
virtù – virtutis arcam – santuario della carità
– caritatis sacrarium
–
patrimonio di spiritualità – pietatis thesaurum –
fonte della santità –
iustitiae
prontuarium.
S.Corrado
lascia la sua patria natale, Calendasco e Piacenza, partendo
pellegrino
alla volta dei luoghi santi di Roma. Giunge dopo un lungo
viaggio
presso la Valle delle Celle per poi trasferirsi ‘alli
Pizzoni’ di Noto in Sicilia.
L’abbandono
della patria terrena fisicamente, è richiesto a chi desidera
vivere
nella solitudine eremitica per darsi quindi alla
contemplazione di Dio.
Questo
abbandono, che prefigura il pellegrinaggio alla patria
Celeste, è
chiamata
“xeniteia”; il Santo Corrado mette in pratica un
corretta
“xeniteia”,
recidendo i legami con la sua terra d’origine, con i
parenti, gli
amici,
cose e beni materiali.
Solo
più tardi, secoli dopo, con la elevazione alla santità, si
riscoprirà la
“originem
terrenam” del Santo Corrado e si ricucirà un aspetto
importante
perduto secoli prima con la xeniteia. Egli lasciando
tutto,
potrà
darsi alle ‘cose’ di Dio in piena libertà dagli affanni
del mondo.
Con
umiltà, coltiva l’oblio delle cose terrene, “immemores
terrenorum”
e
disprezza la ricchezza “abiciunt divitias”, sceglie
la povertà “egere
malunt”
per avere la speranza ed il desiderio dei beni celesti.
S.
Corrado guarda benigno alla piccola minoranza positiva
dell’eremo di
Calendasco
e da essa trae forza: qui temprerà il suo spirito nel periodo
più
decisivo e cruciale di tutta la sua ascesa religiosa. Gli
eremiti
penitenti
di Calendasco che lo hanno accolto alla prima conversione,
sono
chiari esempi di ottima vita di pietà religiosa ed
evangelica, di
progresso
morale e spirituale.
Egli
accetta la proposta religiosa-spirituale dei penitenti
francescani, essa
richiede
una adesione alla fede così assoluta e radicale che lo
spingerà
esplicitamente
alla scelta ascetica e monastica quale espressione ottimale
del
“secessus” dal mondo.
E’
la conversione che “significa assumere un modo diverso di
pensare e
di
agire… significa liberarsi dagli idoli che ci siamo creati e
che legano
il
cuore”.
Ritirato
alfine nella grotta fra la brulla montagna della valle di
Noto,
S.
Corrado si dedica allo studio della Sacra Scrittura in maniera
intensa.
Corrado
quando giunge presso la grotta di Noto è già da un pezzo
‘ricco
di
Cristo’; spogliato dei beni terreni ora vale più dei
giovani per l’età e
più
dei vecchi per la santità; ha la mente illuminata e con
intensità brama
a
quel luogo di solitudine, dimenticato.
Corrado
è convinto che i beni da lui trattenuti sarebbero stati una
distrazione
continua per il pensiero. Essendo il pensiero rotto dal
possesso
dei beni, i ‘pensieri superiori’ sulle cose spirituali e
di
comunione
fraterna ne sarebbero anche essi distolti.
Non
è facile entrare nella coscienza di Corrado in modo netto e
chiarificante
ma
possiamo sostenere con quasi certezza che la svolta è stata
estrema. Si
legge
nella pergamena che fu deposta nel sarcofago del santo, che ne
narra
la
Vita, che “Il beato Corrado fu di Lombardia, di
una città chiamata
Piacenza,
ed egli fu dei maggiori uomini e gentili di Piacenza”.
Corrado,
sotto la guida del padre spirituale Aristide nel romitorio di
Calendasco,
impara
che i sani non
frequentano
la casa di cura: “Dio è la vita e la salvezza di quanti
ha voluto
creare,
proprio di tutti, fedeli e infedeli, giusti e ingiusti, pii ed
empi,
schiavi
delle passioni o liberi da esse, monaci e secolari, dotti e
indotti,
sani
e ammalati, giovani e non più giovani. Essendo effusione di
luce e
sole
degli spiriti, a questi concede la sua luce in misura diversa
ma in
modo
imparziale, perchè in Dio non c’è accezione di persone. Il
cristiano
secondo
l’umana possibilità imita il Cristo aderendo in parole
opere e
pensieri
alla fede nella santa Trinità, correttamente e
irreprensibilmente
il
cristiano non trascurerà di fare del bene per quanto sta in
lui.”
Si
noti come Francesco d’Assisi mostri un recupero
dell’esperienza
spirituale
antica, quando afferma a chi è rivolto il messaggio
evangelico:
“qualsiasi
fedele, ricco, povero, nobile, non-nobile, senza valore,
brillante,
0prudente,
semplice, chierico, illustre, laico nel popolo cristiano”.
Corrado
è stato folgorato da questa frase: accortosi che Dio è vita
e salvezza
aderisce
secondo la sua possibilità a Cristo, la sua vita secolare,
sebbene
nobiliare
cavalleresca, non gli è di impedimento ad una conversione
piena.
Questa
conversione significa due cose: 1) ricominciare da zero la sua
vita
materiale,
adattandola al monachesimo-penitenziale e 2) coltivare una
vita
spirituale graduale, che porti l’affidamento fatto nella
fede, ad una
maturazione
profonda ed unica in Dio.
Corrado
non si è tirato indietro: una conversione totale, al pari del
suo
padre
spirituale nell’ideale di povertà e cioè il Santo
d’Assisi Francesco,
che
ormai in quegli anni tanto aveva segnato le genti e gli animi.
E del
francescanesimo
era già da tempo, dagli anni della sua più fortunata
diffusione,
che Corrado ne respirava l’ideale.
Michele
Di Gabriele
|
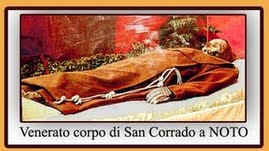





 Un libro imperdibile
Un libro imperdibile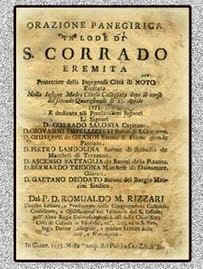
 La Vita
in spagnolo
La Vita
in spagnolo